Questo blog ospita la tesi discussa il 19 maggio 2006 alla Scuola Superiore di Counseling di Torino. Il titolo della tesi è quello del blog. Ogni post è un capitolo. Sarebbe ovvio cominciare con l’introduzione, ma l’introduzione la troverete nel commento a questo post, che conterrà invece il primo capitolo.
Uno dei ricordi più vividi della mia infanzia mi vede nella stanza che al tempo condividevo con mio fratello; nel ricordo però sono sola, la musica di accompagnamento è quella dello Zecchino d’Oro, a volte cantata da me, altre ascoltata da un 33 giri di vinile. Sono sola e, insieme alla musica, l’unico altro elemento del gioco è un palloncino di quelli che negli anni Sessanta a Torino si vendevano quasi solo in occasione del Carnevale in piazza Vittorio. Ricordo che lo portavo a casa (quello del ricordo è bianco, ma ce ne devono essere stati molti altri) e per un giorno il palloncino non si scostava dal soffitto se io non mi aggrappavo al filo e lo tiravo giù. Non era quello però il gioco. Il gioco poteva avvenire soltanto il giorno dopo quando, persa una sufficiente quantità di elio per via del calore nella stanza, il palloncino cominciava a scendere e presto non sarebbe più stato in grado di volare.
Quello era il mio momento.
Per un tempo che adesso mi appare di ore e ore (avevo una grande capacità di restare sola da bambina e una concentrazione quasi autistica su gesti ripetitivi attraverso i quali la mia mente si ampliava, viaggiava e raggiungeva dimensioni che i giochi condivisi mi precludevano), giocavo cantando e rivolgendo al palloncino frasi di incoraggiamento mentre con la mano lo sospingevo verso il soffitto, insegnandogli nuovamente a volare.
È stata la mia prima “esperienza” di insegnante, ed era diversa da quando a casa del nonno (di nuovo per ore e ore in solitudine) “correggevo” cataloghi con la matita rossa e blu, giocando alla maestra. Col palloncino c’era la musica e la dimensione aerea, c’era l’incoraggiamento e non la stigmatizzazione degli errori, c’era il movimento e non l’immobilità che legava la brava bambina al tavolo della cucina di adulti che avevano senz’altro scordato come si fa a giocare, e forse anche a chiacchierare.
Figlia di un’insegnante che aveva rinunciato alla carriera, e probabilmente alla vocazione, per amore e ubbidienza a convenzioni di un’Italia post bellica, sono cresciuta con un ritornello nelle orecchie: che quello dell’insegnante è il più bel mestiere che ci sia per una donna, perché permette di coniugare scuola e famiglia (non nel caso di mia madre, evidentemente); così non ho fatto l’hostess (volare doveva essere un grande amore per me) come avrei voluto adolescente, non ho seguito le orme di mio padre a cui forse non sarebbe dispiaciuta una figlia manager, ma finita l’università ho fatto l’insegnante, o meglio la supplente, per un paio d’anni.
Fare la supplente non è la stessa cosa che fare l’insegnante, soprattutto a ventitre anni con l’apparecchio sui denti. È un lavoro che assomiglia molto di più al babysitting anche se i baby hanno dai 14 ai 20 anni, usano lo skateboard in classe e spengono le sigarette sulle mani dei compagni.
Il ricordo del mio primo giorno di scuola si spegne in un attacco di bile nella notte: il vomito nero che mai prima avevo conosciuto, e neppure dopo. Non erano stati i ragazzi a procurarlo, anche se la prima volta in classe mi aveva dato non poca agitazione. Dovevo supplire per quindici giorni a inizio d’anno un docente di tedesco non ancora nominato, ma contemporaneamente si era assentato il collega di inglese, e quindi mi ero trovata davanti una classe spaccata a metà, due lingue diverse, nessun libro e nessuna intenzione da parte dei ragazzi di fare lezione davanti a una appena ventenne, con la qualifica da film per soli adulti di “supplente di lingue”.
Ero fiera però di essere riuscita a contenerli, di aver evitato che usassero lo skate in classe e che si arrampicassero alle sbarre che chiudevano le finestre del piano terra per impedir loro di uscire da quella parte (un sistema non troppo illuminato alla fine dei progressisti anni Settanta per tenere gli allievi in classe, ma era una zona molto difficile della città).
Il trauma infatti mi aveva attesa a pranzo quando, raccontando le mie peripezie, ricevetti una paternale dai miei genitori. La mia mamma ex insegnante (in una scuola parrocchiale di sole ragazze nei primi anni Cinquanta) mi intrattenne sui suoi metodi efficaci per mantenere la disciplina. Mio padre (amministratore delegato di successo, ma che non aveva mai insegnato neppure un’ora) mi indottrinò su come avrei dovuto condurre quella lezione. L’entusiasmo del “primo giorno di scuola” naufragò in un profondo senso di inadeguatezza. Di lì l’attacco di bile.
A distanza di anni ho imparato ad apprezzare la preoccupazione con cui il giorno dopo mio padre mi annunciò che, qualora avessi ancora avuto reazioni di tale intensità, mi avrebbe impedito di tornare a insegnare; sul momento però la presi come una sfida. Avrei dimostrato loro di cos’ero capace. E così da 25 anni racconto come un fiore all’occhiello di quella volta in cui, sì e no un mese dopo, nel laboratorio linguistico mi si è avventato contro, con coltello a serramanico aperto, l’allievo a cui avevo dato una nota per aver insultato il tecnico di laboratorio (che, spaventato, affermava di non aver sentito nulla e si rifiutava di accompagnarlo dal preside) e di come sia stata salvata dall’unica ispezione dell’Ufficio di Igiene a cui abbia assistito in ventisette anni di scuola.
Poco dopo l’episodio del tentato accoltellamento, la supplenza nel liceo di barriera finì e io andai ad insegnare per il resto dell’anno nel liceo linguistico privato che avevo frequentato fino a quattro anni prima. I licei linguistici pubblici erano ancora da venire, e negli anni Ottanta la popolazione scolastica di quelli privati era, come tuttora nella maggior parte delle facoltà di lingue, composta per almeno l’80% di ragazze, mediamente tranquille, mediamente “di buona famiglia”, mediamente “non problematiche”. In una classe però, la popolazione maschile, nella figura dell’unico elemento, sembrava racchiudere in sé tutti i problemi che le sue compagne non evidenziavano. Era un quindicenne biondo, dai tratti morbidi che contrastavano con il personaggio che aveva creato. Un giorno mi aveva portato un libro fotografico sui ragazzi di stadio, e mi aveva mostrato con orgoglio la foto che lo ritraeva mentre sugli spalti brandiva una catena. Altre volte nell’intervallo mi aveva offerto a mo’ di merendina della droga leggera. Poco più grande di lui, interpretai questi segni come una richiesta d’aiuto. Convocai, separatamente, i genitori separati ed entrambi si trovarono straordinariamente d’accordo sul fatto che sarebbe stato meglio che io badassi agli affari miei e non a quelli del loro figlio.
Anche quella supplenza finì e l’anno dopo mi trovai a condurre i laboratori d’inglese pomeridiani in una tormentata scuola media del quartiere Vallette, esperienza che mi convinse di non essere portata all’insegnamento della fascia d’età fra gli 11 e i 13 anni. Ad anno quasi finito, il giorno del mio compleanno, nella pagina di cronaca cittadina trovai un articolo che mise fine – e al tempo pensavo sarebbe stata una conclusione definitiva – alla mia carriera di insegnante: il mio allievo “problematico” dell’anno precedente aveva trovato la morte lanciandosi a tutta velocità a cavallo di una moto non sua, e che per l’età non avrebbe potuto guidare, contro un’auto condotta… da un insegnante.
Decisi che quel mestiere non faceva per me, provai altre strade e infine partii per gli Stati Uniti alla ricerca di una nuova specializzazione.
Ma mentre ero in California a studiare giornalismo, in Italia uscì il tanto atteso (non da me!) concorso a cattedre. Mia madre rispolverò la mai sopita vocazione e, con la complicità della mia amica del cuore e di un amico notaio, mi iscrisse al concorso. Tornando nell’estate mi scoprii impigliata nelle maglie concorsuali. Per la mia disciplina nelle scuole superiori del Piemonte c’erano 12 posti e 1500 candidati. Non avendo studiato nulla di specifico per il concorso ritenevo di non correre rischi. Da figlia obbediente sostenni le due prove scritte, e fui non poco sorpresa quando seppi che il mio nome compariva fra i 150 che erano passati all’orale. Sostenni la prova e la superai. Ma ero ancora tranquilla: non ero certo fra i 12 migliori candidati. Né andai in Provveditorato il giorno dell’assegnazione delle cattedre. Una telefonata mi annunciò che, per quanto io scappassi, la cattedra mi aveva raggiunta: sulle montagne che ancora non sognavano di essere olimpiche, in un istituto professionale per il turismo, c’erano cinque classi di ragazzi ad attendermi.
Piansi, e non di gioia.
Per più di tre lustri tentai di tutto per procurarmi una carriera alternativa. Adoravo i miei studenti – da quella prima classe di diplomati nel mio primo anno di ruolo (su undici studenti, due si laurearono poi in inglese e sono diventati entrambi insegnanti) a tutte quelle che erano seguite: negli istituti professionali, tecnici, per ragionieri, per geometri, diurni e serali – ma non volevo insegnare.
Così presi borse di studio all’estero, conseguii un Master in letteratura comparata, tradussi libri, mi diedi all’organizzazione di eventi culturali, mi tuffai nel volontariato, appena uscita la legge sul lavoro a tempo parziale ne approfittai… eppure in ogni tentativo di fuga mi ritrovavo sempre a insegnare: fiabe in U.S.A., traduzione in Italia, letteratura ai pensionati dell’Università della Terza Età, allattamento alle mamme, you name it, I taught it!
Finché un giorno su un treno lessi un articolo che avrebbe cambiato la mia vita. Parlava del counseling, un mestiere nuovo nell’Italia sull’orlo del nuovo millennio, un mestiere che sembrava essere fatto apposta per me. Tra gli indirizzi consigliati, uno era proprio a Torino, proprio a due passi da casa mia. E offriva un corso di avvicinamento al counseling: tre incontri mi sono bastati a capire che quella era la mia strada. Invece dell’insegnante avrei fatto il counselor!
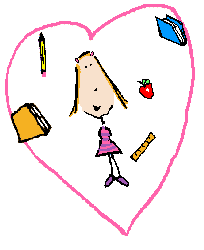
18 Maggio 2006 – 21:53
INTRODUZIONE
Sono passati cinque anni da quando ho cominciato a frequentare i corsi di counseling, quasi un liceo… Fin dal primo anno ho notato uno strano effetto collaterale che non mi aspettavo certo quando, decidendo di dare una svolta alla mia vita e alla mia professione, mi ero iscritta alla SCUOLA SUPERIORE DI COUNSELING: insegnare cominciava a piacermi davvero e, a mano a mano che mi appassionavo a quel mestiere a cui avevo lungamente cercato di sfuggire, intravedevo la possibilità di coniugare quel che facevo con quel che stavo imparando a fare. Questa tesi è la sintesi del mio percorso e raccoglie i materiali che ho sviluppato e applicato sistematicamente negli ultimi tre anni.
Il PROLOGO è dedicato al racconto di come sono diventata, mio malgrado, insegnante. Illustra, se ce ne fosse bisogno, come i semi di pensieri gettati nell’infanzia, fioriscano quando e come meno ce l’aspettiamo. Il secondo capitolo presenta LE BASI scientifiche a cui mi ispiro: Roberto Assagioli, Piero Ferrucci, Diana Whitmore e la Psicosintesi in genere. Nel terzo esamino alcuni degli ALTRI STIMOLI che in questi anni hanno contribuito a dare forma alla mia figura di educatore: Alice Bailey, Maharishi e il Consciousness-Based Education Program, Thomas Gordon, le costellazioni famigliari secondo il metodo di Bert Hellinger, e in particolare l’applicazione di Marianne Franke-Gricksch per la scuola, Alexander Neill e le scuole “utopistiche”.
Il capitolo dal titolo IL PERCORSO esplicita il mio piano di lavoro attraverso il quinquennio liceale: IN PRIMA: conosci te stesso 101, si forma il gruppo, le regole di convivenza, l’obiettivo comune, i sogni son desideri; IN SECONDA: il corpo è il mio veicolo, le energie che mi percorrono, la scienza; IN TERZA: apro il libro della vita, le emozioni queste sconosciute, diario delle vacanze, è arrivato un bastimento carico di….; IN QUARTA: cogito ergo sum, scienza e letteratura, tutto è energia; IN QUINTA: qual è la mia strada? che ci faccio qui? dove voglio andare? La letteratura sonda la psiche, ritorno al mito, storie di guerra e di pace. Il capitolo GLI STRUMENTI invece presenta alcune tecniche che applico trasversalmente nelle cinque classi: il circle time, la scrittura, lo show and tell, la “cinematerapia”, il gioco, la valutazione e l’auto-valutazione e il coinvolgimento degli studenti nelle scelte che li riguardano.
Nell’EPILOGO ho affrontato i punti su cui sento di voler lavorare nel futuro, i passi che mi sono proposta di affrontare. Segue un’APPENDICE che contiene alcuni esercizi in lingua inglese e materiale per me importante che non ha trovato una collocazione altrove nella tesi, e infine la BIBLIOGRAFIA in cui non ho citato tutti i libri che hanno concorso alla mia educazione all’insegnamento, né quelli citati direttamente nella tesi, ma semplicemente un percorso di avvicinamento, in lingua italiana, a Roberto Assagioli e alla Psicosintesi.
Questa tesi è dedicata a mia madre che mi ha “costretta” a fare l’insegnante. A Susanna Basso, Dea Duranti, Emanuela Bernascone, Barbara Lanati, Valentina Carosso, Adela Novach, Monica Bregola, Irene Pulzoni, Stefania Como che mi hanno insegnato a farlo. A TUTTI i miei allievi che mi hanno sopportato e supportato fino ad oggi e che – lo so – continueranno a farlo, nonostante tutto. E a Laura Baruffaldi, perché c’è, sempre.
Il mio ringraziamento speciale va alla Vita e all’Energia che la anima. La ringrazio per aver creduto in me, e per l’amorevole saggezza con cui mi permette di continuare a sbagliare.
Greetings! Very helpful advice in this particular article!
It is the little changes which will make the largest
changes. Many thanks for sharing!